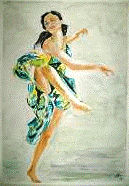Andrea Pinotti è docente di Estetica all’università Statale di Milano. Si occupa di teorie dell’immagine e dei rapporti fra estetica e storia delle arti visive, con particolare riguardo per la cultura di lingua tedesca fra Otto e Novecento. Il suo ultimo libro è Il rovescio dell’immagine edito da Tre Lune.
Sopraffatti dalle
immagini, non sappiamo dire più che cosa sia davvero
un’immagine. Sono necessari strumenti che ci aiutino a
interpretare la “cultura visuale” in cui siamo
immersi, senza relegarci nella posizione di spettatori inerti.
D. Partendo dal suo libro, Teorie dell’immagine, siamo sopraffatti dalle immagini, allora le chiedo che cosa è un’immagine? E come non rimanerne sopraffatti?

R. La nozione d’immagine è una nozione molto complessa e getta le sue radici nei primordi del pensiero filosofico e della sua storia. Platone, uno dei padre della filosofia, ha distinto nel mondo dell’immagine un eicon, che sarebbe diventato l’icona e quindi un’immagine capace di mostrare il modello di cui essa stessa è immagine mantenendo le giuste proporzioni. Questo eicon è distinto da un eidolon, che sarebbe diventato l’idolo, ed è un immagine più capace di illusione anche di mistificazione e di falsità. È un immagine che deforma il modello, è un’immagine potenzialmente ingannevole. Platone nel complesso aveva una certa diffidenza nei confronti delle immagini, le riteneva dei dispositivi capaci più di allontanarci dall’esperienza della verità che non il contrario; nel dialogo Sofista lui fa questa distinzione che ha avuto un’importanza fondamentale nel corso della storia del pensiero. Un’immagine che sa avvicinarsi alla percezione vera del reale ed una al contrario che ci allontana da questa realtà. L’immagine dovrebbe essere intesa come “immagine di”, se io penso ad una ritratto è l’immagine di qualche cosa che a sua volta non è un’immagine. Il ritratto di Carlo V: Carlo V è un essere umano e l’immagine è il suo ritratto. Oggi si sente dire che in questa civiltà cosiddetta delle immagini questo rapporto indicato dal di, questa rappresentazione dell’immagine nei confronti della realtà è qualcosa che è collassato
D. Quindi non c’è più l’immagine di?
R. Non c’è più l’immagine di. Sentiamo spesso discutere sui giornali e in televisione certi psicologi che dicono “Il bambino si è buttato dalla finestra perché non aveva più la percezione del reale in quanto totalmente plasmato sul modello del videogioco” per cui è sempre possibile il new games, il reset, ecc. La morte nel videogioco non è mai irreversibile
D. Non è cambiato molto se pensiamo ai nostri tempi quando cartoni animati come Willy Coyote viveva esperienze estreme come i massi che gli cadevano in testa e la dinamite…eppure non li abbiamo emulati
R. Oggi si è intensificato. Lei infatti ha citato questo aspetto dei cartoni animati che già Walter Benjamin negli anni ’30 aveva osservato in alcuni paragrafi del suo testo L’opera d’arte nell’epoca riproducibilità tecnica ha osservato proprio questo. Michy Mouse, proprio nel presentarsi come un’esperienza di ripetute violenze iperboliche però mai aventi un effetto reale sul modo dei rapporti e delle persone, già allora costituiva una domanda filosofica per Benjamin. Ci sono però alcuni teorici che condividono la diffidenza che anche lei ha citato, cioè dicono: “Ma siamo sicuri che l’immagine sia poi questa cosa che si è sostituita alla realtà, siamo sicuri che si possa dire come ha detto Bodriare che la prima guerra del Golfo non è mai esistita perché ci è arrivata solo la sua rappresentazione televisiva? Forse no, forse come ci dice lo storico dell’arte Georges Didi-Huberman “Attenzione, qui abbiamo a che fare con una specificità della singola immagine, non lasciamoci andare a delle argomentazioni generalistiche che riguardano l’immagine nel suo complesso”. Didi-Huberman esprime un’esigenza etica, trovare il tempo di meditare sulla nostra esperienza, sulla mia esperienza nei confronti di questa immagine che qui davanti a me mi interroga. Questo per evitare due forme diverse di censura. È un’opinione di Didi-Huberman che mi sento di condividere in pieno. Quando si parla di censura si pensa ad una istanza, un’autorità politica o religiosa che ci sottrae l’immagine alla vista che ci impedisce di vedere, che ci tiene nascosto qualcosa per esercitare in maniera più efficace il controllo sulle nostre menti, sulle nostre credenze. Questa è una forma di censura che ancora oggi sussiste anche in circostanze insospettate. Bill Gates della Microsoft ha seppellito nel deserto in un bunker enorme una quantità di immagini di cui ha acquisito i diritti di riproduzione di cui ha avviato un lentissimo processo di acquisizione scannerizzato di queste immagini e questo comporta una serie di interrogativi. Come una potenza finanziaria incarnata in un singolo individuo possa diventare detentrice di diritti di riproduzione e diffusione di milioni e milioni di immagini?
D. Può sottrarle come vuole?
R. Può sottrarle. Questa accumulazione che è sembrata una sorta di collezionismo pervertito e deformato, da un certo punto di vista sembrerebbe un gesto di conservazione e amore per l’immagine, ma in realtà finisce per essere un gesto di censura perché le sottrae all’utilizzazione e alla condivisione collettiva. Però per Didi-Huberman c’è un’altra forma di censura che è quella che si produce non per difetto, non perché vengono tolte le immagini alla nostra vista, ma perché ce ne vengono date troppe. È un’esperienza che tutti facciamo quotidianamente davanti ad un telegiornale in cui ci sono queste insalate di immagini che possono riguardare, in brevissimo lasso di tempo, di tutto: immagini tragiche, immagini comiche, immagini del quotidiano banale, immagini dell’evento eccezionale. E tutto questo montato insieme in questa rapida successione induce ad un annullamento del senso, nessuna immagine accostata in questo montaggio è capace di esaltare il valore della singola immagine, anzi è un montaggio produttore di non senso, di appiattimento, di banalizzazione, di neutralizzazione
D. Con questo sistema ci fanno accettare cose che non si potrebbero accettare?
R. Esatto, perché è una sorta di anestesia. È una anestesia procurata non per mancanza di percezione come nella censura classica, ma per eccesso di percezione, per bombardamento di percezione. Un caso esemplare è quanto siamo ormai anestetizzati, che vuol dire letteralmente incapaci di esperienza estetica (an-àisthesis), davanti all’immagine di violenza che ci provengono da tutte le parti del mondo. Il bombardamento delle immagini è molto spesso un bombardamento di immagini di bombardamenti. Da questo punto di vista l’antologia che ho curato con Antonio Somaini Teorie dell’immagine voleva essere un tentativo di re-imparare a porsi in una maniera interrogativa. Un film è sempre meno un’esperienza che consumiamo come spettatori in una sala cinematografica, ma che sempre di più diventa il film visto sul nostro computer o sullo schermo della stazione o su quello della metropolitana. Questa circolazione della immagini pone delle domande intorno allo statuto dell’opera stessa: che cosa è un film oggi? Con questa antologia ci siamo posti l’intento, tra gli altri, di iniziare a risollevare una serie di questioni. Una molto urgente riguarda l’insieme di immagini che tradizionalmente la cultura umanistica occidentale non ha voluto prendere in considerazione concentrandosi su quelle considerate immagini per eccellenza, cioè le immagini della storia dell’arte. Opere belle esemplari, opera del genio, risultato di una grande abilità tecnica nel manipolare i materiali, nel sapere usare il pennello…capaci di suscitare un’esperienza estetica di commozione. Il problema è che l’arte non c’è sempre stata, è esistita una fase dell’umanità in cui l’esperienza artistica come la intendiamo non esisteva. Se noi guardiamo le caverne con i graffiti preistorici che i nostri manuali di storia dell’arte inseriscono come primi capitoli della storia dell’arte, è molto dubbio che si possa parlare di arte a quello stadio perché erano pratiche in cui la nozione di arte non si era ancora staccata da un istinto di simbolizzazione. Arrivando al novecento possiamo dire che ci sarà un tempo, o forse siamo già in quel tempo, in cui arte non c’è più. Il grande tema della morte dell’arte che già Hegel aveva già messo a fuoco nelle sue lezioni di estetica dei primi decenni dell’800. Che cosa ci fa distinguere una scatola del supermercato da una brillo box identica ma un’opera d’arte di Andy Warhol?
D. Che cosa ce la fa distinguere?
R. Generazioni di filosofi si sono spaccati la testa, il dibattito è ancora aperto. È un dibattito che è soprattutto molto aperto nel mondo dell’Estetica analitica, la tradizione anglosassone che ha molto lavorato sulla definizione di arte cercando di capire se arte abbia qualcosa a che fare con delle proprietà dell’oggetto. Altri asseriscono che l’opera d’arte non è mai da sola, ma si porta dietro un mondo che la configura come opera d’arte. In un certo periodo è considerata arte magari in altro ambiente e in un’altra cultura no
D. Pertanto è relativo al contesto?
R. Esatto. Il problema dell’immagine non artistica è anche cercare di capire qual è il tipo di esperienza che viene prodotta da una serie di immagini che sono presenti nella nostra quotidianità e che forse non abbiamo ancora gli strumenti per interpretare. Le radiografie per esempio, tutto quel che riguarda le immagini scientifiche, immagini astronomiche, le immagini della fisica. Che cosa facciamo con tutte queste immagini? Ci sono immagini che riguardano, e qui ci sono problemi etici, la nostra identità biologica. Quando è stata introdotta l’ecografia in 3D del feto, ha modificato il concetto di persona, il dibattito sull’embrione e di conseguenza quello sull’aborto
D. Ecco che le immagini assumono un diverso compito
R. Le immagini vanno al di là della sfera propriamente estetica, diventano costitutive di determinate nozioni fino ad investire problemi di carattere etico, politico. Pensi alla delicatissima questione della immagini di sorveglianza, ormai tutta la nostra esperienza dello spazio è video sorvegliata. Forse siamo la prima epoca che produce una gran quantità di immagini che nessuno mai guarderà
D. A meno che accade qualcosa
R. A meno che ci sia un omicidio o un fatto per cui induce a controllare, salvo scoprire che quella volta lì la telecamera non funzionava… C’è una vignetta dello street art inglese Banksy che fa vedere un angolo di muro, c’è una telecamera che punta da una parete l’altra parete e su quella parete c’è una scritta “Ma cosa stai guardando?” rivolta alla telecamera stessa. Quelle delle telecamere sono produzioni di immagini apparentemente prive di intenzionalità, queste macchine, una volta collocate, non hanno un’intenzionalità umana che le diriga
D. La telecamera coglie ciò che passa sotto il suo occhio
R. Questo è un mondo che noi non possiamo semplicemente subire
D. E le immagini scientifiche?
R. Tutti noi abbiamo avuto esperienza. Pensiamo ai nostri libri di fisica e chimica accompagnati da una serie di illustrazioni e noi, dice James Elkins, abbiamo sempre sottovalutato queste illustrazioni come se fossero ausili per dei soggetti che non arrivavano a comprendere la teoria che era esposta più chiara, chi non arrivava a comprendere il ragionamento astratto aveva l’immagine. Queste immagini sono state considerate in modo strumentale, le immagini erano utili ma se si fossero tolte non avrebbe compromesso la comunicazione della verità. Pensiamo però all’uso dei diagrammi nella preparazione della teoria, orientava i ricercatori in una direzione anziché in un’altra. I primi virologi nel ‘900 che si erano immaginati gli anticorpi hanno iniziato a lavorare su modelli grafici ci tenevano a sottolineare che quei disegni erano indicativi e non pretendevano di dire che gli anticorpi erano davvero fatti così, poi col tempo si sono trovate delle analogie tra i disegni e la realtà. Qui è un caso in cui l’immagine precede l’elaborazione scientifica
D. Lei ha ben spiegato come la filosofia estetica possa contribuire alla scoperta scientifica e al cammino della scienza, ma all’uomo della strada cosa può dare? Come ci si avvicina ad un’immagine?
R. Se c’è un compito che la filosofia può avere in questo caso è quello di problematizzare l’ovvio. L’ovvio, il banale, lo scontato è qualcosa che è diventato così, non lo è sempre stato. E questo è il caso del bombardamento delle immagini. Forse la Filosofia, in quanto esercizio della domanda più che non la formulazione di una risposta, permette di fare un passo indietro e di uscire da questa ovvietà e di interrogarla. Da questo punto di vista una riflessione sull’immagine in senso filosofico penso abbia soprattutto questo valore, il fatto di respingere l’ovvio, in senso fenomenologico di metterlo in epochè, di sospenderlo, di sospendere l’ovvietà per interrogarla
D. Questa interrogazione è già iniziata?
R. Sì, da una quindicina d’anni. Nel mondo anglosassone, negli Stati Uniti e in Germania si parla di svolta iconica. Svolta iconica è uno slogan che può essere ridimensionato, ma è la presa di coscienza della visione maturata negli anni ’60-’70 sotto il nome di svolta linguistica per cui il metodo fondamentale della scienze umane era un metodo elaborato sul terreno della linguistica. Ci siamo abituati a espressioni come “il linguaggio dell’artista, il linguaggio del fotografo, …”. Questa tendenza ad applicare al di fuori della sfera linguistica il termine linguaggio è indice di un problema che consiste nel fatto che le parole fanno una cosa e le immagini un’altra
D. Questo va decisamente sottolineato
R. E sì, lo dice anche il senso comune. Pensiamo al proverbio “Un’immagine vale più di mille parole” Sono dei poteri diversi quelli dell'immagine rispetto alla parola. Quando dico verde riesco a sintetizzare innumerevoli esperienze
D. Forse confondiamo il termine linguaggio con comunicazione perché l’immagine comunica non parla
R. Certo. Questa svolta iconica Ikonische Wende come la chiamano in Germania, o pictorial turn come la chiamano negli Stati Uniti, per indicare che non si ha a che fare con pittura ma con la picture nel senso di immagine concreta. In realtà si potrebbe rintracciare una svolta iconica prima degli ultimi quindici anni. Potremmo dire che lo stesso Platone era un rappresentante perché in lui troviamo, al di là di ciò che dicono i manuali che era il grande nemico delle immagini, in lui troviamo delle analisi molto approfondite. Comunque negli studi delle immagini è ormai nata la consapevolezza che è necessario elaborare per le immagini un metodo che non le appiattisca sulla comunicazione verbale. Poi andando in giro si può vedere facilmente come in qualunque manifesto pubblicitario immagine e parola collaborino. Si tratta di capire come i due mondi collaborino. C’è un esempio che cita Mike Ball nella nostra antologia, è una teorica che lavora ad Amsterdam, lavora sulla parola e sull’immagine, racconta un aneddoto che spiega cosa vuol dire fare oggi una teoria dell’immagine. Ball racconta che un suo collega d’università riceve una cartolina che ha un’immagine su un lato e un testo dall’altro. La cartolina è un pastello riproduzione di Toulouse Loutreche che mostra due bambini sotto le coperte che stanno dormendo, si vedono appena le teste e non si capisce se siano maschi o femmine. Il testo della cartolina dice “Caro professore, ho apprezzato molto le sue lezioni mi piacerebbe poterle approfondire con lei in qualche occasione.” Era firmato da una studentessa di questo docente. Quando la cartolina è arrivata sia il docente, ma soprattutto sua moglie, hanno percepito immediatamente il messaggio erotico che era veicolato. Il messaggio erotico nasce dall’interazione tra immagine e scrittura. Allora dice la Ball una storia dell’arte analizzando il pastello non avrebbe mai potuto arrivare all’interpretazione erotica del quadro, una linguistica non avrebbe mai potuto ricavare da quella frase un esplicito invito sessuale. Il senso non sta solo nella parola e non solo nell’immagine
D. E l’interpretazione era corretta?
R. Sì, perché dopo qualche mese il professore ha lasciato la moglie
D. Quindi la moglie aveva interpretato correttamente…Veniamo all’ultima domanda. Quanto influisce l’esteriorità nelle scelte giovanili?
R. Da questo punto di vista una bella tradizione che si interessa di esteriorità, immagine e cultura, è la filosofia della moda o estetica della moda. Tutti quelli che si sono occupati soprattutto George Simmel che nei primi del ‘900 dedica un saggio al tema della moda, ma anche autori più vicini come Roland Burt, hanno visto tutti in questa apparentemente futile esteriorità un problema filosofico. Un problema paradossale per Simmel perché, grazie alla moda, io mi identifico in un gruppo, mi vesto come quel gruppo per bisogno di omologazione e di appartenenza e allo stesso tempo in virtù di quello che mi metto addosso io posso distinguermi dagli altri. Sono le due facce dello stesso bisogno, cioè è un apparire e allo stesso tempo ne va dell’identità e della differenza che sono due concetti che si tengono insieme un po’ come il caldo e il freddo. Dobbiamo tener presente la grande differenza tra i tempi in cui Simmel scriveva e i tempi attuali. Nei primi del ‘900 c’era un’alta società che determinava la moda e gli strati inferiori della società che guardavano all’alta società come un modello che cercavano di imitare, ma quando l’avevano raggiunta l’alta società si era già spostata potendo permettersi di influenzare i cambiamenti della moda, così era sempre un passo più avanti. Oggi non si può più pensare ad un imitato e ad un imitabile. Soprattutto perché nelle culture giovanili abbiamo a che fare con il mondo frammentato e polimorfo della sottocultura, perciò il rapporto dialettico tra identità e differenza è presente ma deve essere pensato in modo diverso, non più come un gruppo sociale che determina il cambiamento dello stile della moda, ma dobbiamo guardare all’interno delle bolle di subcultura che creano dei modelli.
Maria Giovanna Farina